Liquidazione giudiziale. Tutta la procedura.
Liquidazione
giudiziale.
Imprenditori individuali e società.
Presupposti della liquidazione e organi preposti.
Siamo giunti alla liquidazione giudiziale.
Come si è visto il legislatore ha preferito nel titolo III del codice regolare le procedure di accesso alla crisi e insolvenza e poi dedicarsi alle singole discipline nei titoli successivi. Con la liquidazione giudiziale si tende, appunto, a liquidare il patrimonio del debitore e soddisfare sul ricavato i creditori.
Come tutte le procedure di questo tipo si accerta l’attivo del patrimoniale del debitore, poi il passivo, cioè valore dei debiti e quindi dei crediti, poi si procede alla liquidazione e distribuzione del ricavato.
Per l’art. 121: Presupposti della liquidazione giudiziale
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.
Quindi i presupposti per la liquidazione giudiziale sono:
1) la qualifica di imprenditore commerciale, sappiamo che l’imprenditore commerciale è quello definito dall’art. 2195 c.c. ma sappiamo anche che questo articolo non riesce a individuare tutti gli imprenditori commerciali, per es. non risolve il problema della c.d. impresa civile. E allora possiamo affermare che sono imprenditori commerciali tutti quelli che non sono imprenditori agricoli, e quindi questi ultimi imprenditori non possono essere sottoposti alla liquidazione giudiziale. Giusto per non creare equivoci anche le società commerciali sono sottoponibili a liquidazione, esclusa la società semplice perché non svolge attività commerciale.
2) che non siano imprenditori che esercitano un’impresa minore ex art. 2 comma 1 lett. d; quindi si può essere sottoposti a liquidazione sempre che si tratti di imprenditore commerciale e non si tratti di un ente pubblico.
3) l’imprenditore commerciale che non sia un imprenditore minore deve trovarsi in stato d’insolvenza, e questo requisito non è mutato rispetto alla vecchia legge fallimentare.
Ci si riporta quanto già scritto sullo stato d’insolvenza.
Prima di andare avanti riportiamo di nuovo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 49; può darsi anche che non si tratti d’impresa minore, tuttavia non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila. Dei concetti di crisi e insolvenza ce ne siamo già occupati quando si è parlato degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
Gli organi della procedura, il tribunale concorsuale
La procedura di liquidazione prevede quattro organi, il tribunale concorsuale, il giudice delegato e il comitato di creditori.
Vediamo secondo l’art. 122 quali sono i compiti e poteri del tribunale, ricordando che questo organo ha la competenza esclusiva per questa procedura, competenza che si divide tra tribunale delle imprese e tribunale ordinario.
-
Art. 122 . Poteri del
tribunale concorsuale
1.
Il tribunale
che ha
dichiarato aperta
la procedura
di liquidazione giudiziale è investito dell'intera procedura e:
a)
provvede alla
nomina, alla
revoca o
sostituzione
per giustificati motivi degli
organi della
procedura, quando
non è prevista la
competenza del giudice delegato;
b) può in
ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei
creditori e il debitore;
c) decide le
controversie relative alla procedura stessa che
non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami
contro i
provvedimenti del giudice delegato.
2. I
provvedimenti del tribunale
sono pronunciati
con decreto
motivato, salvo che la legge non preveda
che il
provvedimento sia
adottato in forma diversa.
Gli organi della procedura, il giudice delegato
Come tutti o quasi tutti sanno il tribunale collegiale, come quello concorsuale, è composto da tre giudici; di questi se ne individua uno che dovrà occuparsi di particolari aspetti della procedura che per decisione del legislatore non è opportuno far svolgere da tutti e tre i giudici del collegio.
In generale per l’art. 123 il giudice delegato, che decide con decreto, esercita funzioni vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura e in particolare:
a) riferisce
al tribunale
su ogni
affare per
il quale
è richiesto un provvedimento del collegio;
b) emette o
provoca dalle competenti
autorità i
provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad
esclusione di quelli che
incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio
diritto incompatibile con l'acquisizione;
c) convoca
il curatore e il
comitato dei
creditori nei
casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno
per il corretto e
sollecito svolgimento della procedura;
d) su
proposta del
curatore, liquida
i compensi
e dispone
l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui
opera è stata
richiesta dal
medesimo curatore
nell'interesse
della
procedura;
e) provvede
sui reclami proposti contro gli atti del
curatore e del
comitato dei creditori;
f) fatto
salvo quanto
previsto
dall'articolo 128,
comma 2, autorizza
il curatore
a stare
in giudizio
come attore
o come convenuto,
quando e'
utile per
il miglior
soddisfacimento dei
creditori.
L'autorizzazione
deve essere
sempre data
per atti
determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado
di essi;
g) nomina
gli arbitri, su proposta del curatore;
h) procede
all'accertamento dei crediti e dei diritti vantati
da terzi sui beni compresi nella procedura, secondo le
disposizioni del capo III.
i) quando ne
ravvisa l'opportunità,
dispone che
il curatore presenti
relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 130,
prescrivendone le modalità.
Ci sono poi i casi di incompatibilità del giudice delegato; questi, infatti, non può trattare i giudizi che ha autorizzato, né far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.
Ricordiamo poi che l’art. 124 dispone un’unica disciplina di reclamo contro i decreti del tribunale o del giudice delegato. Contro i decreti del giudice delegato, il reclamo va proposto al tribunale.
Contro i decreti del tribunale, il reclamo va proposto alla corte d’appello.
Il curatore
Il curatore, nella visione del codice, è amministratore, manager e anche liquidatore del patrimonio del debitore.
I sui compiti emergono nello stesso svolgimento
della procedura, ma il codice, dagli articoli
La nomina
(art. 125)
È nominato nella sentenza che dichiara liquidazione giudiziale, nell’esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale (art. 127). Viene scelto nell’albo previsto dall’art. 356 e con i requisiti richiesti dall’art. 358.
L’accettazione (art. 126)
Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione. Intervenuta l'accettazione, l'ufficio comunica telematicamente al curatore le credenziali per l'accesso al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia. Se il curatore non osserva questo obbligo il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.
Modalità di
esercizio delle sue funzioni, la delega (art. 129, 132)
Il curatore esercita personalmente le sue funzioni ma con l’autorizzazione del comitato dei creditori, può delegare ad altri delle specifiche operazioni, escluse però quelle dell’art. 198, 200, 205.
Il curatore con l’autorizzazione del comitato dei creditori e previa comunicazione al giudice delegato, se gli atti sono di valore superiore cinquantamila euro, può effettuare riduzioni di crediti, transazioni, compromessi, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli altri atti di straordinaria amministrazione. Nel richiedere l’autorizzazione il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.
Gestione
della procedura e responsabilità del curatore (art. 128, 131,136)
Amministrazione del patrimonio del debitore: il curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.
Modalità di svolgimento dei suoi compiti: deve svolgere i suoi compiti con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e deve annotare le sue operazioni giorno per giorno in apposito registro informatico consultabile telematicamente.
Poteri processuali del curatore: di regola non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato. Non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale, ma può assumere la veste di difensore, se in possesso della necessaria qualifica, nei giudizi avanti al giudice tributario quando sia funzionale ad un risparmio per la massa.
Conto della gestione: il curatore che cessa dal suo ufficio, deve rendere il conto della gestione a norma dell'articolo 231, comunicandolo anche al curatore eventualmente nominato in sua vece, il quale può presentare osservazioni e contestazioni.
Svolgimento delle operazioni di liquidazione: il curatore procede alle operazioni di liquidazione contemporaneamente alle operazioni di accertamento del passivo.
Reclamo contro gli atti del curatore: contro gli atti di amministrazione del curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, con ricorso al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell’atto.
Reclamo contro le omissioni del curatore: in questo caso gli otto giorni per il reclamo decorrono dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere.
Decisione del giudice delegato con decreto: il giudice delegato, sentite le parti, decide sul reclamo, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio e se il reclamo è accolto, il curatore deve conformarsi alla decisione del giudice delegato.
Impugnazione della decisione del giudice delegato: contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124.
Revoca del
curatore (art. 134)
Revoca: il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare con decreto motivato e sentito lo stesso curatore e il comitato dei creditori.
Impugnazione del decreto del tribunale: contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di
revoca del curatore è ammesso il reclamo alla corte di appello previsto dall'articolo 124. Il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.
Sostituzione
del curatore (art. 135)
Al fine di evitare conflitti di interessi, il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta e verificata l’assenza di conflitto di interessi in capo ai creditori istanti, provvede alla nomina del nuovo curatore.
Relazione e
rapporti riepilogativi (art. 130)
Chiudiamo questa parte sul curatore accennando al fatto che il curatore deve redigere nei termini previsti dall’art. 130 relazioni e i rapporti riepilogativi; si tratta di attività che il curatore deve compiere in termini molto stringenti, per esempio entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale il curatore, presenta al giudice delegato un’ informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause della insolvenza e alla responsabilità del debitore o degli amministratori e degli organi di controllo della società. La relazione è trasmessa in copia integrale entro cinque giorni dal deposito al pubblico ministero.
Il comitato dei creditori
Secondo l’art. 140 il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, o su richiesta del tribunale o ancora del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni. Vediamo le caratteristiche fondamentali trattate dal codice dall’art. 138 all’art. 141.
Nomina (art. 138 comma 1): è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze documentali, sentito il curatore e tenuto conto della disponibilità ad assumere l'incarico e delle altre indicazioni eventualmente date dai creditori con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente.
Costituzione del comitato: Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione della nomina da parte dei suoi componenti comunicata al curatore che ne informa immediatamente il giudice delegato.
Composizione (art. 138 comma 2): è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi. La composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.
Delega delle funzioni: ciascun componente del comitato dei creditori può delegare, a sue spese, a un avvocato o a un dottore commercialista, in tutto o in parte, l'espletamento delle proprie funzioni, dandone comunicazione al giudice delegato.
Rimborso spese e compenso: ai membri del comitato spetta il rimborso delle spese (art. 140 comma 6).
Atti di ispezione: il comitato e ogni suo componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al debitore. Se il comitato non riesce a svolgere il suo incarico (art. 140 comma 4) gli stessi poteri possono essere esercitati da ciascun creditore, previa autorizzazione del giudice delegato.
Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori (art. 141): contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori, il curatore, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto.
Il giudice delegato decide sul reclamo sentite le parti, omessa ogni formalità non
indispensabile al contraddittorio. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124.
Delle modalità delle deliberazioni del comitato se ne occupa l’art. 140 e per la responsabilità i membri del comitato devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta per la natura dell’incarico e sono responsabili della verità delle loro attestazioni, devono conservare il segreto su fatti e documenti di cui vengano a conoscenza durante il loro incarico (art. 140 comma 7).
Effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale per il debitore.
Gli articoli da
Vediamo tutto nelle pagine che seguono
I beni compresi e esclusi nella liquidazione giudiziale (artt. 142, 144,146,147), lo spossessamento: l’effetto più rilevante dell’apertura della procedura di liquidazione giudiziale sta nello spossessamento.
Per l’art. 142 primo comma: “ La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale”. Anche i beni che pervengono al debitore dopo l’apertura della liquidazione giudiziale sono compresi nella liquidazione, detratte le passività per l’acquisto e la conservazione degli stessi. Se quindi il debitore vince una lotteria, le somme vinte rientrano nella liquidazione, come anche può accedere per un legato o un’eredità. Tuttavia alcuni beni del debitore possono essere esclusi dalla liquidazione giudiziale. I primi sono oggetto di specifica rinuncia da parte del curatore (art. 142 comma 3); per questi beni non conviene procedere alla liquidazione.
Poi abbiano beni che possiamo definire essenziali per il debitore ex art. 146 come i beni e i diritti di natura strettamente personale o gli assegni di carattere alimentare.
Come visto il debitore è spossessato dei suoi beni, ma perde anche la proprietà? No, almeno fino a quando e beni non saranno alienati. Il debitore, quindi, può anche compiere dopo l’apertura della liquidazione giudiziale degli atti su i suoi beni, può alienarli, costituirvi sopra diritti reali di godimento.
Tali atti non saranno nulli, ma inefficaci rispetto ai creditori, inopponibili, come anche si dice (art. 144 comma 1).
Ciò vuol anche dire che se la procedura si chiude senza che si sia giunti alla liquidazione, questi atti, validi ma inefficaci, acquisteranno la loro piena efficacia.
Del resto sono anche inefficaci rispetto ai creditori le formalità (es. trascrizioni, iscrizioni) necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale (art. 145).
Capacità processuale del debitore (art. 143): il debitore perde la capacità processuale attiva e passiva sui rapporti di natura patrimoniale sui beni oggetto della procedura. Al suo posto sta in giudizio il curatore.
Obblighi del debitore: con la liquidazione giudiziale il debitore deve sottostare a una serie di obblighi come l’obbligo consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale (art. 148) o di presentarsi se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura (art. 149).
Effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale per il creditore.
L’apertura della liquidazione giudiziale comporta una sorta di paralisi dei poteri che normalmente sono riconosciuti ai creditori, tanto che l’art. 150 dispone che: “Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”.
Ma dobbiamo chiederci, chi sono i creditori che partecipano alla liquidazione giudiziale?
Sono quelli che erano tali fino al giorno in cui è stata pronunciata la sentenza di liquidazione giudiziale, e questi creditori sono i creditori concorsuali. Per l’art. 151, infatti: ” La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore”.
La liquidazione giudiziale non abolisce le differenze tra creditori chirografari e privilegiati; questi ultimi dovranno essere comunque preferiti secondo le regole dell’art. 153.
La disciplina dei crediti pecuniari, interessi, scadenza, crediti
condizionali e infruttiferi (art. 154 e 156)
- Sospensione del corso degli interessi: la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura oppure fino all'archiviazione disposta ai sensi dell'articolo 234, comma 7, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dall'articolo 153, comma 3 secondo il quale per i crediti con privilegio generale il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto finale.
- Scadenza dei crediti pecuniari: la dichiarazione di dichiarazione giudiziale fa considerare scaduti tutti i crediti pecuniari che non erano ancora scaduti nel giorno della data di apertura della liquidazione giudiziale.
- Crediti condizionali: partecipano al concorso secondo le regole degli artt. 203, 226, 227. Sono compresi nei crediti condizionali anche quelli che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale. In altre parole sono considerati condizionali perché bisogna attendere prima l’escussione del debitore principale e vedere l’esito di questa; per questo motivo sono considerati condizionali.
- Crediti infruttiferi: i crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale sono ammessi al passivo per l'intera somma, ma ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del saggio stabilito dall'articolo 1284 del codice civile, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.
Disciplina
dei crediti non pecuniari e dei crediti derivanti da obbligazioni o
altri titoli di debito.
- Disciplina dei crediti non pecuniari: i crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale (art. 156).
- Disciplina dei crediti derivanti da obbligazioni o altri titoli di debito: crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale, detratti i rimborsi già effettuati; se e' previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.
La
compensazione
Chiediamoci se il creditore può opporre in compensazione un suo credito durante la procedura di liquidazione; bisogna distinguere (art. 155):
a) il credito da opporre in compensazione è sorto prima dell’inizio della procedura concorsuale: la risposta è sì, il creditore potrà opporre la compensazione, anche se il credito non era ancora scaduto prima dell’apertura della procedura concorsuale.
b) credito sorto per atto tra vivi dopo la domanda cui è seguita la procedura di liquidazione: non è possibile opporre in compensazione questo credito con i crediti del debitore sottoposto a liquidazione.
Creditori di
più coobbligati solidali
Può darsi che la liquidazione giudiziale riguardi più coobbligati in solido, magari soci di una società di persone, nei confronti dello stesso creditore (art. 150).
In tal caso il creditore concorre nella liquidazione giudiziale di ogni debitore per l’intero credito per capitale e accessori fino al totale pagamento. Tra i coobbligati il regresso sarà possibile solo dopo che il creditore sia stato interamente soddisfatto.
Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai
creditori.
Uno dei compiti del curatore è di acquisire all’attivo della procedura il maggior numero di beni appartenenti al debitore, sempreché questi beni non siano usciti dal suo patrimonio.
Di conseguenza se il debitore prima dell’apertura della procedura ha compiuto atti di alienazione su beni del suo patrimonio, o costituito garanzie, il curatore dovrà tenerne conto non facendo rientrare nell’attivo tali beni e rispettando le garanzie costituite.
Può però accadere che questi atti siano stati compiuti quando il debitore già si trovasse in stato d’insolvenza e esiste la rilevante possibilità che siano stati compiuti proprio per la situazione d’insolvenza in cui versava l’imprenditore finendo così per favorire certi creditori, che hanno avuto quel che gli spettava, e sfavorendo altri creditori che al momento della liquidazione del patrimonio del debitore, non riusciranno a soddisfare il loro credito, vista “l’emorragia” di beni che sono usciti dal patrimonio dell’imprenditore prima dell’apertura della liquidazione giudiziale.
Per porre rimedio a questa situazione gli articoli 163 e ss. del codice stabiliscono quali atti del debitore, poi sottoposto a liquidazione, possano essere inefficaci nei confronti dei creditori ammessi alla procedura, quali atti, in altre parole possono essere revocati.
Si parla quindi di revocatoria, che una volta si chiamava revocatoria fallimentare, che non è altro che un forma particolare e speciale della generale azione revocatoria prevista dall’art. 2901 che comunque può essere esercitata dal curatore.
Ciò posto dobbiamo schematizzare le varie ipotesi.
1) Atti
automaticamente revocati, cioè automaticamente inefficaci nei confronti
dei creditori ammessi alla procedura di liquidazione, artt. 163 e 164.
-
Atti a titolo gratuito
automaticamente revocati se compiuti dal debitore dopo il deposito
della domanda da cui è scaturita la procedura di liquidazione o
nei due anni anteriori
al deposito della domanda cui è seguita la procedura di liquidazione
giudiziale. Sono privi
di effetto rispetto ai creditori gli
atti a titolo
gratuito, esclusi i
regali d'uso
e gli
atti compiuti
in adempimento di un dovere morale o a scopo di
pubblica utilità,
in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del
donante.
In questi casi i beni oggetto degli atti sono acquisiti al patrimonio della liquidazione giudiziale mediante trascrizione della sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura concorsuale, ma ogni interessato può proporre reclamo contro la trascrizione a norma dell'articolo 133.
- Pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o successivamente, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda da cui è scaturita la procedura di liquidazione o nei due anni anteriori al deposito della domanda cui è seguita la procedura di liquidazione giudiziale. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori.
- Rimborsi dei finanziamenti dei soci se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore alla domanda cui è seguita la liquidazione giudiziale. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori.
Quest’ultimo caso fa riferimento all’ipotesi in cui la società rimborsi nei periodi di tempo indicati dei finanziamenti ai soci; questa regola, quindi, non si applica se il rimborso non è stato effettuato ai soci ma altre società finanziatrici o terzi.
L’art. 164 terzo comma, tuttavia, estende la regola appena vista anche al rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.
2) Atti
automaticamente revocati, cioè automaticamente inefficaci, salvo che
l’atra parte provi di non essere a conoscenza dello stato d’insolvenza
del debitore poi sottoposto a liquidazione giudiziale. Si tratta in
genere di atti non normali nell’esercizio di un’impresa (art. 166 comma
1).
a) Atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita la liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore al deposito di detta domanda.
b) Atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita la liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore al deposito di detta domanda.
c) I pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore al deposito di detta domanda per debiti preesistenti non scaduti.
d) I pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori al deposito di detta domanda per debiti scaduti.
3) Atti
revocati solo se il curatore dimostra che l’altra parte era a conoscenza
dello stato d’insolvenza. Si tratta di atti normali nell’esercizio di un
impresa.
- Questi atti sono revocati solo in seguito ad esercizio di azione revocatoria da parte del curatore e sempre che lo stesso curatore provi che l’altra parte fosse a conoscenza dello stato d’insolvenza del debitore e sono: i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori al deposito di detta domanda.
Il curatore deve quindi agire se vuole ottenere la revocazione di questi atti, ma l’art. 166 comma terzo, esclude dalla revocatoria alcuni atti tra cui ricordiamo i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso e le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio.
L’azione revocatoria, infine, può essere esperita dal curatore anche contro gli atti che incidono sui patrimoni destinati a uno specifico affare ex art. 2247 bis primo comma lettera a).
Gli atti compiuti tra coniugi, parti di un unione civile o conviventi di
fatto.
La prescrizione della revocatoria e l’esercizio della revocatoria
ordinaria.
Una volta per gli atti compiuti tra coniugi, esisteva la presunzione muciana, poi abrogata. Attualmente l’art. 169 si occupa degli atti compiuti tra coniugi parti di un unione civile o conviventi di fatto e in particolare, prende in considerazione gli atti previsti dall’art. 166 di cui abbiamo parlato e cioè gli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie delle quali ci siamo occupati al punto 3) del paragrafo precedente e gli atti a titolo gratuito. Ebbene gli atti compiuti tra queste persone, per es. tra i due coniugi o conviventi di cui uno è il debitore, sono revocati alle seguenti condizioni:
a) gli atti devono essere stati compiuti nel tempo il cui il debitore esercitava un’impresa;
b) se si tratta di atti a titolo gratuito sono stati compiuti più di due anni prima della data di deposito della domanda cui è seguita la liquidazione giudiziale;
C’è un modo per l’atra parte del rapporto di matrimonio, unione civile, convivenza per evitare la revocazione? Sì, c’è ma non è semplice, in quanto queste persone devono provare che non erano a conoscenza dello stato d’insolvenza del debitore, coniuge, convivente di fatto o parte di un’unione civile.
A questo punto è doverosa un’osservazione; abbiamo visto che la posizione delle parti non debitrici del rapporto familiare è molto svantaggiosa, perché la revocazione può avvenire praticamente senza limiti di tempo. Fortunatamente per queste persone vi sono i termini di decadenza e prescrizione delle azioni revocatorie e di inefficacia che possono essere esercitate dal curatore previste dal codice.
Per l’art. 170 del codice: “Art. 170 limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia
Le azioni
revocatorie e
di inefficacia
disciplinate nella
presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre
anni dall'apertura
della liquidazione
giudiziale e
comunque si
prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto”.
Il decreto correttivo 147\2020 ha aggiunto un secondo comma all’art. 170 che così recita:“Quando alla domanda di accesso a una procedura concorsuale segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso”.
Il riferimento è ai termini per gli atti a titolo gratuito (163), gli atti “non normali” nell’esercizio di un’impresa (164) e gli atti “normali” (166 commi 1 e 2). Nei casi previsti dal nuovo comma 2 dell’art. 170 si fanno retrocedere a un momento più lontano nel tempo i termini di prescrizione.
Chiudiamo il paragrafo ricordando che il curatore anche se sono scaduti i termini dell’art. 170 e nei casi non previsti dalla revocatoria nelle liquidazione giudiziale, può agire con le revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Per l’art. 165, infatti: “Art. 165. Azione revocatoria ordinaria.
Il curatore
può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal
debitore in pregiudizio dei creditori,
secondo le norme del
codice civile.
L'azione si
propone dinanzi al tribunale competente
ai sensi
dell'articolo 27 sia in confronto del contraente
immediato, sia
in confronto dei suoi aventi causa
nei casi
in cui
sia proponibile
contro
costoro”.
Il pagamento di una cambiale scaduta
In via generale il pagamento di una cambiale scaduta potrebbe essere revocato con un’azione da parte del curatore, in quanto si tratta di un pagamento di un credito liquido e esigibile, tuttavia la situazione in questo caso si presenta più complessa, e bisogna chiedersi…
Chi ha ricevuto il pagamento, quindi il creditore cambiario, poteva rifiutare il pagamento senza subirne un danno? Se il rifiuto del pagamento comportava per il creditore la perdita del diritto di regresso nei confronti di altri obbligati cambiari, questo pagamento non potrà essere revocato, se invece non c’era questo pericolo, sarà possibile revocare questo pagamento.
Ma ammettiamo che il pagamento di questa cambiale non possa essere revocato per i motivi appena detti, cosa potrà fare il curatore? Il curatore potrà agire contro l’ultimo obbligato in via di regresso (magari il traente di una cambiale tratta) dimostrando che quando ha tratto o girato la cambiale conosceva lo stato d’insolvenza del debitore.
Se riesce a fornire questa prova l’ultimo obbligato in via di regresso dovrà restituire al curatore ciò che aveva riscosso per la trasmissione della cambiale al curatore (art. 168).
Effetti della revocazione
Quando gli atti di cui abbiamo parlato sino ad ora sono stati revocati, si produce la revocazione e la conseguenza sarà la restituzione alla procedura di liquazione da quanto ricevuto dal debitore, e tutto andrà ad aumentare l’attivo da distribuire ai creditori, ma che fine fanno quelli che hanno subito la revocazione?
L’art. 171 ci spiega tutto.
Per il secondo comma del 171: “
Colui
che, per
effetto della
revoca
prevista dalle
disposizioni precedenti, ha
restituito quanto
aveva ricevuto è
ammesso al passivo della liquidazione giudiziale per il suo eventuale
credito”.
In altre parole diventa un creditore insoddisfatto ed è per questo che è ammesso al passivo.
L’art. 171, infine si occupa degli effetti della revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966; in questo caso la revocatoria si esercita e si effettua nei confronti del destinatario della prestazione.
Effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale sui rapporti
giuridici pendenti.
L’apertura della liquidazione giudiziale provoca il blocco dell’attività imprenditoriale del debitore, salvo che non ne sia disposta la continuazione e sarà comunque necessario stabilire la sorte dei rapporti giuridici pendenti, cioè dei contratti che l’imprenditore aveva stipulato che non sono stati ancora eseguiti o solo parzialmente eseguiti. Il codice detta una disciplina generale all’art. 172 applicabile a tutti i tipi di contratti stipulati e una particolare, in tutto o in parte derogatoria della disciplina dell’art. 172 relativa a specifiche figure contrattuali o rapporti giuridici.
Vediamo, quindi, la disciplina generale dell’art. 172 che però non deroga alle norme speciali previste per i contratti pubblici (art. 172 comma 6).
- Contratto ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione giudiziale: l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, oppure di sciogliersi, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.
L’effetto generale per questo tipo di contratti è quindi la sospensione del rapporto fino alla decisione del curatore, debitamente autorizzata dal comitato dei creditori, sulla prosecuzione o scioglimento.
L’altra parte, quindi, resta in attesa della decisione del curatore, ma, d’altro canto, non può aspettare all’infinito. Ed è per questo che il secondo comma dell’art. 172 concede al contraente in attesa una actio interrogatoria volta a fargli conoscere la sorte del suo contratto. Il contraente può quindi mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. Il contratto può quindi proseguire o sciogliersi, vediamo cosa accade in entrambi i casi.
1) prosecuzione del contratto: in caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili
soltanto i crediti maturati nel corso della procedura e quindi non quelli maturati in precedenza.
2) scioglimento del contratto: in caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale l’eventuale credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.
Queste sono le regole generali poi ci sono moltissime regole particolari relative a singoli contratti, ricordiamo ad esempio i contratti di carattere personale dove è previsto lo scioglimento automatico (art. 175) all’apertura della liquidazione giudiziale, salvo che il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso dell'altro contraente, manifesti la volontà di subentrarvi, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi o i contratti. Per i contratti di locazione di immobili la disciplina è più complessa. Bisogna distinguere ex art. 185 il caso in cui sia sottoposto a liquidazione giudiziale il locatore o il conduttore.
Cominciamo dal primo caso, in sostanza il locatore che aveva dato in fitto un immobile è sottoposto a liquidazione giudiziale.
1) Il locatore è sottoposto a liquidazione giudiziale: l'apertura della liquidazione giudiziale non scioglie il contratto di locazione di immobili e il curatore subentra nel contratto.
2) Il conduttore è sottoposto a liquidazione giudiziale: in questo caso il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo (insinuato al passivo come credito concorsuale) per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.
Come abbiamo visto nel caso in cui sia sottoposto a liquidazione giudiziale il locatore, il contratto prosegue, ed è anche logico, perché il canone di locazione sarà acquisito all’attivo.
Ma può accadere che alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale, la durata residua del contratto sia superiore a quattro anni.
In questo caso il curatore, entro un anno dall'apertura della procedura, può, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo (insinuato al passivo come credito concorsuale) per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dall'apertura della procedura.
Regole particolari valgono per il contratto di edizione le cui sorte e regolata da leggi speciali.
Ricordiamo, infine, che l’art. 189 detta una complessa disciplina per i contratti che hanno ad oggetto rapporti di lavoro subordinato e il licenziamento collettivo da parte disposto dal curatore ex art. 189.
Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione
giudiziale.
Siamo tornati a parlare della procedura e siamo giunti al punto in cui, dichiarata la liquidazione giudiziale il curatore prende possesso dei beni del debitore per accertare, in primo luogo, il passivo della liquidazione giudiziale, però non decide lui perché il curatore forma un progetto di stato passivo, ma sarà il giudice delegato a renderlo esecutivo. Ma come siamo arrivati a questo punto? Siamo giunti dopo che è stata proposta davanti al tribunale domanda per la liquidazione giudiziale, e il tribunale ritenendo che esistesse la qualifica di imprenditore commerciale del debitore, che non si trattasse di impresa minore, e che vi fosse l’insolvenza dichiara la liquidazione giudiziale con sentenza che ha il fondamentale contenuto previsto dall’art. 49 e che abbiamo già visto in precedenza come per tutti gli altri aspetti procedurali circa la fase di apertura della liquidazione giudiziale, come il rigetto della richiesta da parte del tribunale e la sua impugnazione, o l’accoglimento e l’impugnazione della sentenza davanti alla corte d’appello, è opportuno rinviare alla lettura di quanto ho già scritto seguendo lo schema del codice, nel capitolo dedicato al titolo III e ai relativi schemi, perché ora ci dobbiamo occupare di cosa deve fare il curatore, dal punto di vista procedurale, una volta che è stato nominato e che ha accettato l’incarico.
Ricordiamo qui, però che in base all’art. 199 con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene assegnato il domicilio digitale ed è formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento cui hanno diritto di accedervi anche i membri del comitato dei creditori e gli altri creditori.
Ciò precisato torniamo al nostro argomento.
Il Capo II si occupa del primo passo che deve compiere il curatore, cioè la custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale e quindi il curatore ne prende materialmente il possesso apponendo se necessario i sigilli.
Abbiamo tre operazioni fondamentali che deve compiere il curatore in questa fase che sono:
1. Apposizione dei sigilli;
2. Inventario;
3. Formazione degli elenchi dei creditori e redazione del bilancio dell’ultimo esercizio dell’impresa sottoposta a liquidazione.
Fase 1. la
ricognizione dei beni del debitore, l’apposizione dei sigilli, la
consegna di titoli e scritture contabili al curatore.
1.a. Sigilli (art. 193).
Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario.
Se non è possibile apporre i sigilli, perché si tratta di cose deteriorabili, il curatore procede secondo quanto dispone l’art. 758 c.p.c. ; in questo caso il giudice disporrà la vendita immediata tramite commissionario.
Può darsi che il curatore trovi difficoltà nella ricognizione o nell’apposizione dei sigilli e in questi casi può richiedere l'assistenza della forza pubblica.
Se poi i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, il giudice delegato può autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o più coadiutori.
1.b. Consegna di titoli e documenti (art.194).
Devono essere consegnati al curatore:
a) il denaro contante;
b) le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti;
c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria.
Questi documenti servono al curatore per rendersi conto della situazione debitoria del debitore.
I titoli e gli altri documenti sono custoditi personalmente dal curatore o, con l’autorizzazione del giudice delegato, affidati in custodia a terzi.
Ogni interessato, se autorizzato dal curatore, può, a sue spese, esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore, ed estrarne copia.
Il denaro eventualmente consegnato al curatore è depositato sul conto corrente della procedura.
Fase 2.
L’inventario (artt. 195 e 196).
Sono stati messi i sigilli, se ciò è stato necessario. Il curatore, poi, rimossi i sigilli procede all’inventario dei beni. Le regole che si seguono sono quelle del codice di procedura civile (art. 769 e ss. c.p.c.).
In effetti in questo caso il curatore svolge anche
delle attività che sono simili a quelle dell’ufficiale giudiziario
durante un pignoramento. In relazione ai beni oggetto dell’inventario vi
può essere istanza al giudice di una parte interessata a che non siano
inclusi certi beni nell’inventario perché dei terzi vantano dei diritti
reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili. Si può
anche chiedere, trattandosi di beni mobili, la restituzione agli aventi
diritto. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il
debitore o, se si tratta di società, gli amministratori a
dichiarare se hanno notizia di altri beni da
comprendere
nell'inventario,
avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo
Fase 3 . La
formazione degli elenchi dei creditori e redazione del bilancio
dell’ultimo esercizio dell’impresa sottoposta a liquidazione (art. 198).
Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, compila l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, e anche l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono poi depositati in cancelleria.
Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella
liquidazione giudiziale.
Siamo rimasti al momento in cui il curatore ha fatto l’inventario e ha ricevuto i libri contabili e i documenti dell’impresa sottoposta a liquidazione.
La procedura si svolge poi in altri semplici passaggi.
1) il curatore in base alla documentazione raccolta e alle informazioni che ha invia avviso ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali sui beni compresi alla liquidazione;
2) i creditori e i titolari dei diritti, o perché avvertiti dal curatore o perché sono a conoscenza dell’apertura della liquidazione giudiziale presentano domanda di ammissione al passivo con ricorso;
3) il curatore esamina le domande e predispone gli elenchi dei creditori e dei titolari dei diritti e predispone e deposita un progetto di stato passivo nei confronti del quale i creditori e i titolari di diritti sui beni potranno presentare le loro osservazioni;
4) si tiene l’udienza fissata per l’esame dello stato passivo davanti al giudice delegato, dove sono esaminate una per una le domande di ammissione al passivo;
5) esaminate le domande il giudice forma lo stato passivo, e lo rende esecutivo con decreto;
6) contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo si potranno proporre opposizioni e impugnazioni;
7) è poi possibile che siano depositate domande tardive di ammissione al passivo.
Approfondiamo alcuni dei punti che abbiamo visto.
Contenuto
della comunicazione del curatore
Il curatore comunica ai destinatari:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e);
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4 ( questo punto è stato introdotto dal decreto correttivo 147\2020 che ha sostituito il precedente punto d) dell’art. 200 ;
e) il domicilio digitale assegnato alla procedura.
Domanda di
ammissione al passivo.
Per essere ammessi al passivo è necessario presentare domanda di ammissione al passivo, e questo vale non solo per i creditori, ma anche per coloro che vantano diritti sui beni sottoposti a liquidazione.
Ricordiamo che la sentenza che dichiara la
liquidazione giudiziale
stabilisce il luogo, il giorno e
l'ora dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo,
entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito
della sentenza, ovvero centocinquanta giorni in caso di particolare
complessità della procedura.
La data della udienza è stata quindi fissata dal tribunale e comunicata dal curatore agli interessati
La domanda si propone con ricorso e devono presentarla coloro che vantano un credito o chiedono la restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura.
Devono anche presentare domanda di ammissione al passivo coloro che chiedono di partecipare al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui.
Dobbiamo ora occuparci del ricorso (art. 201).
Sono due gli elementi da considerare, la comunicazione del ricorso e il suo contenuto. Veniamo al contenuto del ricorso ex comma 3 dell’art. 201.
Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1; se manca o risulta assolutamente incerto uno dei requisiti di questa lettera il ricorso è inammissibile.
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca; se manca o risulta assolutamente incerto uno dei requisiti di questa lettera il ricorso è inammissibile.
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; se manca o risulta assolutamente incerto uno dei requisiti di questa lettera il ricorso è inammissibile.
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale; se manca o risulta assolutamente incerto uno dei requisiti di questa lettera il credito è considerato come chirografario.
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni e' onere comunicare al curatore.
Se manca l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario le comunicazioni saranno effettuate in cancelleria (si applica l'articolo 10, comma 3).
L’udienza
per l’esame dello stato passivo.
All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, si avrà, o si potrà avere, il contraddittorio tra curatore e coloro che hanno fatto domanda di ammissione al passivo.
Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con
le esigenze di speditezza del procedimento.
Terminata l’eventuale istruzione, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati, il
giudice delegato, decide su ogni domanda anche in assenza delle parti.
In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi. Il debitore può chiedere di essere sentito e delle operazioni si redige processo verbale. Anticipiamo che alla fine dell’udienza, esaminate le domande, il giudice forma lo stato passivo, e lo rende esecutivo con decreto.
Le domande presentate sono esaminate una per una dal giudice delegato che ex art. 204 che con decreto succintamente motivato, le accoglie in tutto o in parte o le respinge o le dichiara inammissibili.
La dichiarazione d’inammissibilità della domanda, tuttavia non ne preclude la successiva riproposizione; in questo ultimo caso il ricorrente che vorrà riproporre la domanda non dovrà commettere gli stessi errori che hanno portato alla dichiarazione d’inammissibilità da parte del giudice (art. 201 comma 4). Il giudice, come visto, può anche ammettere le domande presentate, ma alcune di loro potranno essere ammesse con riserva, e oltre ai casi previsti dalla legge, il giudice ammette con riserva:
a) i crediti condizionati e quelli indicati all'articolo 154, comma 3 cioè quei crediti ( ritenuti comunque condizionati) che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale.
b) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, a condizione che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;
c) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore
può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.
Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.
Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre
opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda (art. 205).
Le impugnazioni del decreto che rende esecutivo lo stato passivo
Regolate dagli articoli 206 e 207 anche in relazione alla procedura che è unica, le impugnazioni contro il decreto sono di tre tipi.
Opposizione: con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta. L'opposizione è proposta nei confronti del curatore. Il termine per agire è di 30 giorni dalla comunicazione del decreto che rende esecutivo lo stato passivo da parte del curatore.
Impugnazione: con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta. L'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore. Il termine per agire è di 30 giorni dalla comunicazione del decreto che rende esecutivo lo stato passivo da parte del curatore.
Revocazione: con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto venga revocato se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile all'istante. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.
Il termine decorre dalla scoperta della falsità, del dolo, dell'errore o dalla scoperta del documento decisivo. Con l’opposizione la contestazione è contro il curatore, nell’impugnazione e contro un altro creditore ammesso al passivo, mentre la revocazione è equivalente alla revocazione dell’art. 395 c.p.c. . Come visto se una parte viene a conoscenza di motivi di revocazione durante il termine per proporre opposizione o impugnazione, userà uno di questi due mezzi d’impugnazione, se invece sono trascorsi questi termini dovrà agire in revocazione.
Con la proposizione dell’impugnazione o dell’opposizione si apre quindi un procedimento che vede come convenuti il creditore o il curatore, ma questi ultimi potrebbero proporre contro il creditore un’impugnazione incidentale tardiva (tardiva perché può essere proposta anche se sono scaduti i termini per impugnare) nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo; tanto per intenderci, può darsi che il curatore aveva chiesto al giudice delegato di non ammettere un certo credito, ma il giudice delegato decide di ammetterlo, ma non per l’importo chiesto dal creditore, ma per la metà del credito vantato.
A questo punto il creditore propone opposizione, perché vuole che il credito sia ammesso per intero, ma il curatore propone impugnazione incidentale, chiedendo, come aveva già fatto, che questo credito non fosse ammesso al passivo. Se nello stato passivo vi sono errori materiali contenuti questi sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del titolare di diritti sui beni o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.
Le domande tardive di ammissione al passivo
Il comma 3 dell’art. 49 sul contenuto della sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale così recita: il tribunale assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione (al passivo);
Da ciò si dovrebbe dedurre che trascorsi i trenta giorni non sarebbe più possibile presentare tali domande, e se proposte, visto che il termine è perentorio, dovrebbero essere dichiarate inammissibili, e invece non è così, perché l’art. 208 prevede che possano essere presentate anche dopo il termine assegnato di trenta giorni prima dall’udienza fissata per la verifica dello stato passivo, e che tali domande dovranno essere considerate tardive.
In effetti si prevedono due ipotesi di domande tardive:
a) domande presentate oltre il termine dei trenta giorni dall’udienza fissata per la verifica dello stato passivo ma non oltre sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, termine che può essere prorogato dal tribunale, in caso di particolare complessità delle procedura nella sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale fino a dodici mesi;
b) domande di ammissione al passivo presentate oltre il termine di cui al punto a).
Per entrambe la procedura successiva è identica, ma diversi sono i presupposti per la loro ammissione.
Quelle previste al punto b) e quindi presentate oltre il termine dei trenta giorni dall’udienza fissata per la verifica dello stato passivo e dopo sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, o dopo il termine prorogato dal tribunale e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, saranno ammissibili solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.
Quando poi
la domanda
risulta manifestamente
inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è
dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o
non ha indicato i
mezzi di prova di cui intende valersi per
dimostrarne la non
imputabilità, il
giudice delegato
dichiara con
decreto, reclamabile ex art.
Quindi per le domande tardive della prima specie, quelle della lett. a) non sono previste particolari giustificazioni per essere ammessi al passivo, per quelle tardive della lett. b) bisognerà provare la non imputabilità del ritardo. Se anche le domande tardive del secondo tipo passino il vaglio dell’ammissibilità, il seguito della procedura è lo stesso per tutte le domande tardive.
In effetti il procedimento di accertamento delle domande tardive è lo stesso di quello previsto per le domande non tardive (art. 203) con le verifiche del curatore, il deposito di osservazioni, e la fissazione di un’udienza dove dovranno essere esaminate queste domande tardive.
Il giudice delegato, infatti, fissa per l'esame delle domande presentate un'udienza entro i successivi quattro mesi salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore dà avviso della data
dell'udienza a coloro che hanno presentato la
domanda e ai creditori già
ammessi al passivo. Si applicano le
disposizioni di
cui agli articoli da
La previsione di insufficiente realizzo
Può darsi che tale sia la sproporzione la tra massa passiva e quella attiva della procedura che sia del tutto inutile proseguire nell’accertamento del passivo perché nessun creditore potrà essere soddisfatto. Della questione se ne occupa l’art. 209 che distingue due ipotesi, cioè quando risulta da subito che non può essere acquisito attivo in misura tale da soddisfare anche uno dei creditori, o quando questo accertamento emerge nel corso della procedura. Di conseguenza il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il debitore, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura. Se l’insufficiente realizzo risulta nel corso della procedura si applicheranno le regole appena viste, in quanto compatibili (art. 209 comma 2); in quest’ultimo caso, quindi, non si farà riferimento all’udienza dell’esame per lo stato passivo, perché questa molto probabilmente si sarà già tenuta. Il curatore comunica il decreto trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 201 e 208 i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo, a norma dell'articolo 124, alla corte di appello, che provvede sentiti il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.
Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione
Come visto le domande possono essere presentate da soggetti non sono creditori, ma che affermano di essere titolari di diritti sui beni sottoposti a liquidazione giudiziale. In questi procedimenti si applicherà un particolare regime di prova, simile a quello previsto per l’opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c. La richiesta di rivendica o di restituzione dovrà essere presentata dal titolare del diritto, tuttavia l’art. 210 fa salve le disposizioni dell’art. 1706 c.c. Il riferimento e alla rivendica delle cose che il mandante può esercitare per gli acquisti del mandatario. Quindi anche il mandante, alle condizioni previste dall’art. 1706 c.c. potrà presentare domanda per le rivendica nella procedura di liquidazione.
Esercizio dell’impresa e liquidazione dell’attivo.
Consideriamo la eventuale continuazione dell’attività d’impresa del debitore, e in questa fase assume rilevanza fondamentale il comitato dei creditori.
Ma andiamo con ordine chiedendoci quando potrà continuare l’attività d’impresa.
L’art. 211 fa riferimento a due ipotesi;
1) decisione presa dal tribunale nella sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale: in questo caso il tribunale autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori; non è richiesto il parere del comitato dei creditori, perché non è stato ancora nominato;questa regola è espressa nel comma 2 dell’art. 211, e su questo comma è intervenuto il decreto correttivo 147\2020 eliminando la parte “se dall'interruzione può derivare un grave danno”. Grazie a questo intervento il tribunale può comunque decidere di continuare l’attività d’impresa del debitore, con l’unico limite del pregiudizio dell’interesse dei creditori.
2) decisione presa dal giudice delegato: su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.
Come si vede la decisione può essere presa dal tribunale in sentenza o dopo dal giudice delegato.
Ma il comitato del creditori, anche nel caso in cui sia stato il tribunale a decidere, deve accettare la continuazione dell’attività d’impresa o può bloccare tale esercizio?
Diciamo subito che il comitato dei creditori deve essere convocato almeno ogni tre mesi dal curatore per essere informato sull’andamento della gestione e per pronunciarsi sull’opportunità della continuazione dell’attività d’impresa, e il comitato può ritenere che non sia opportuno continuare questa attività e, di conseguenza, il giudice delegato ne ordina la cessazione.
Ciò fa intendere che la continuazione dell’attività d’impresa avviene nell’interesse principale dei creditori, e non per altri interessi, come quello dei dipendenti dell’impresa al mantenimento del posto di lavoro. Anche il tribunale può ordinare la cessazione dell’attività d’impresa quando ne ravvisi l’opportunità, e decide con decreto sentiti il curatore e il comitato dei creditori, ma in questo caso non sembra che il comitato abbia un potere di veto sulla decisione del tribunale.
La gestione dell’impresa, come detto, è affidata al curatore, che però non può partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto.
Ogni sei mesi , o comunque alla conclusione del periodo di esercizio, il curatore deve depositare un rendiconto dell'attività e in ogni caso deve informare senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio. Ma adesso sorge un altro problema; ammettiamo che l’impresa continui nel sua attività, chi mai le farà credito, considerando che è sottoposta a liquidazione giudiziale? Quale nuovo creditore farà credito sapendo poi che per essere soddisfatto dovrà andare in concorso con i vecchi creditori? A risolvere il problema ci pensa il comma 8 dell’art. 211 che dichiara questi nuovi crediti prededucibili ex art. 221 comma 1 lett. a). Questi creditori non sono creditori concorsuali perché il loro credito e sorto dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, e il loro credito deve essere soddisfatto prima dei creditori concorsuali.
I contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non decida si sospendere l’esecuzione o sciogliersi, ma quando cesserà l’attività d’impresa, si applicheranno le regole previste per la sorte dei contratti pendenti in seguito all’apertura della liquidazione giudiziale (artt. 172 e ss.) di cui abbiamo già parlato.
Un caso particolare riguarda l’affitto dell’azienda o di sui rami, un modo vantaggioso per recuperare denaro e non far cessare l’attività d’impresa. L’art. 212 prevede questa eventualità. Per affittare l’azienda è necessario che il curatore sia autorizzato a farlo.
La procedura si svolge in questo modo:
1) proposta del curatore rivolta al giudice delegato che può essere presentata anche prima della redazione del programma di liquidazione;
2) parere favorevole del comitato dei creditori;
3) autorizzazione del giudice delegato dell’azienda o di suoi specifici rami. Il giudice delegato darà l’autorizzazione al curatore quando l’affitto appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.
Il curatore è quindi stato autorizzato all’affitto, o almeno a cercare un affittuario.
Il curatore dovrà quindi far stimare l’azienda, e provvederà a approntare adeguate forme di pubblicità. Ora una considerazione: perché l’affittuario dovrebbe stipulare il contratto di affitto visto che non ne diviene proprietario e dovrà comunque restituirla?
Certamente perché vede delle possibilità di guadagno, ma anche perché il contratto potrebbe assicurargli una prelazione sull’acquisto dell’azienda o del suo ramo nella fase di vendita dei beni sottoposti a liquidazione.
Il programma di liquidazione predisposto dal curatore
Il curatore per procedere alla vendita dei beni del debitore sottoposti alla procedura, deve predisporre un preciso programma di liquidazione nei modi indicati dall’art. 213, ma viene da chiedersi se tutti i beni del debitore che teoricamente possono essere sottoposti a liquidazione siano poi realmente convenienti da liquidare. In effetti il secondo comma dell’art. 213 introduce il concetto di liquidazione manifestamente non conveniente. Il curatore previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. Ma come fa il curatore a decidere se la liquidazione è manifestamente non conveniente? Lo stesso articolo 213 fornisce una presunzione di liquidazione manifestamente non conveniente. Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione quando dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi.
Ma veniamo al programma di liquidazione. Il curatore deve ricordarsi di due termini per redigere il programma di liquidazione, e cioè 60 e, soprattutto, 150 giorni. L’art. 213 comma 1 dispone, infatti, che il curatore entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il rispetto del termine di 150 giorni da parte del curatore è essenziale, perché il mancato rispetto del termine appena indicato senza giustificato motivo costituisce una giusta causa di revoca dall’incarico. La struttura e il contenuto del programma di liquidazione sono analiticamente indicati nell’art. 213, ricordiamo che il programma deve essere diviso in sezioni, nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Deve inoltre indicare il entro il quale avrà inizio l’attività di liquidazione, e può anche prevedere la liquidazione anticipata; in questo caso prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all’interesse dei creditori. Una volta redatto, il programma è trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione. Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato.
Gli articoli 214 e 215 si occupano di particolari modalità di cessione di beni e diritti dei beni del debitore. L’art. 214 si occupa delle vendita dell’intera azienda del debitore, o di un suo ramo.
Il curatore, infatti, potrà scegliere di vendere singoli beni o diritti del debitore solo quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.
Quindi il curatore deve verificare prima la convenienza di tali cessioni, e solo se accerta che è meglio vendere i singoli beni procederà in tal senso.
Le vendite dell’azienda o di sui rami saranno effettuate secondo le regole della liquazione che vedremo in seguito e in con il rispetto dell’art. 2556 c.c., cioè secondo le regole sulla forma della cessione d’azienda. L’acquirente dell’azienda secondo le regole dell’art. 2560 c.c. comma 2 dovrebbe rispondere anche dei debiti dell’azienda ceduta se risultano dai libri contabili obbligatori, e ciò renderebbe molto meno attraente la cessione d’azienda. Ma il terzo comma dell’art. 214 stabilisce che salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle azienda ceduta sorti prima del trasferimento. Il curatore, inoltre, può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 c.c. e osservate le disposizioni inderogabili contenute nel codice. Il curatore, infine, può anche cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione e anche cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono
già pendenti. In alternativa alla cessione può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.
Le modalità della liquidazione dei beni del debitore
Abbiamo visto che il curatore nei tempi previsti dal codice deve preparare un programma di liquidazione, ma le modalità della liquidazione sono stabilite dal codice all’art. 216.
Questo articolo prevede quattro fasi necessarie e una fase eventuale sulla sospensione delle operazioni di vendita o di impedimento del trasferimento della proprietà (art. 217).
Vediamo le fasi necessarie
1) la stima dei beni: i beni dell’ attivo sono stimati da esperti nominati dal curatore ex art. 129, comma 2 con apposita relazione.
2) le modalità di vendita: per il comma 4 dell’art. 216 le vendite sono effettuate con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo che tali modalità siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base delle stime di cui abbiamo parlato assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Il curatore informa il giudice delegato delle attività di liquidazione nelle relazioni ex art. 130, comma 9. Particolari regole sono previste per la vendita di beni immobili.
3) le offerte di acquisto: gli interessati a presentare l'offerta di acquisto formulano tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di esaminare i beni in vendita. L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito nell’avviso pubblicato dal curatore sul portale delle vendite pubbliche o nell'ordinanza di vendita o se l'offerente non presta cauzione nella misura indicata.
Le offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito. Il bene sarà aggiudicato a chi presenta l’offerta più alta.
4) il pagamento dei beni acquistati e trasferimento del bene all’acquirente: le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente. La vendita dei beni immobili e dei beni iscritti in pubblici registri sottoposti a liquidazione produce un effetto purgativo analogo a quello della vendita dei beni espropriati tanto che il secondo comma dell’art. 217 dispone che relativamente ai beni appena citati, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. Delle vendite effettuate il curatore deve tenere il relativo conto e secondo l’articolo 223 bisogna distinguere i conti della massa attiva immobiliare, da quella mobiliare. Si applicano alla vendita, in quanto compatibili, gli articoli 569, 585 e 587 c.p.c..
5) la fase eventuale sulla sospensione delle operazioni di vendita o di impedimento del trasferimento della proprietà: per l’ art. 217 il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi. Si può anche impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo.
Il curatore, come si vedrà meglio nello schema, dovrà provvedere a redigere un prospetto delle somme disponibili e se l’entità del passivo lo permette, un progetto di distribuzione di dette somme e trasmettere il tutto ai creditori che potranno anche impugnare il progetto del curatore.
Cosa accade nel caso in cui pure essendovi delle somme da distribuire il curatore non redige il prospetto delle somme disponibili?
Per il sesto comma dell’art. 220 questo inadempimento costituisce giusta causa di revoca del curatore.
Ma vediamo in dettaglio nello schema che segue il procedimento di ripartizione.
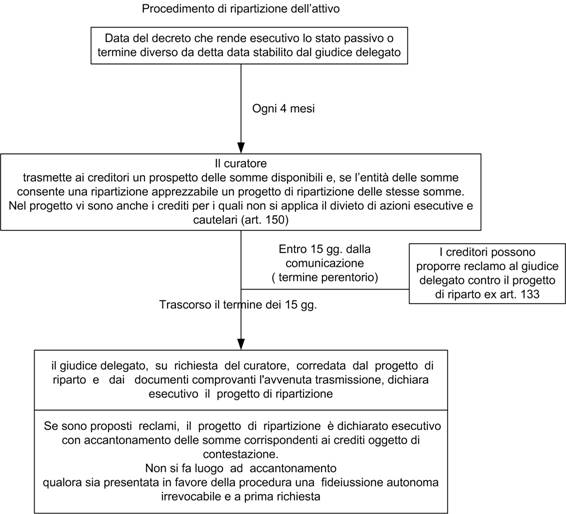
Contro il decreto che rende esecutivo il progetto di ripartizione, possono essere state proposte le impugnazioni ex art. 206.
Ordine di distribuzione delle somme ai creditori, e distribuzione ai
creditori che hanno proposto domanda tardiva di ammissione al passivo
Vediamo ora, ex art. 221 l’ordine di distribuzione delle somme ai creditori.
Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:
a) per il pagamento dei crediti prededucibili;
b) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
c) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera b), qualora non
sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi siamo rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo;
d) per il pagamento dei crediti postergati.
Come si vede l’art. 221 fa una classifica, dove al primo posto vi sono i crediti prededucibili al secondo quelli relativi ai creditori privilegiati, poi i chirografari e in ultimo i postergati.
Eppure c’è un’altra categoria di creditori che potrebbero uscire dalla classifica, e sono i creditori che hanno presentato domande tardive di ammissione al passivo ex art. 208.
Questi creditori se le loro domande sono state accertate, partecipano anche loro alla ripartizione. ma potrebbe essere accaduto che prima della loro ammissione già siano state ripartite delle somme;
Disciplina dei crediti prededucibili
I crediti cui spetta in via prioritaria la distribuzione sono quelli prededucibili, ed è il codice che volta per volta indica quali siano i crediti prededucibili. Ma i crediti prededucibili devono essere ammessi perché sono tali, e quindi in via automatica, o anche loro devono passare al vaglio di ammissibilità come tutti gli altri crediti? La regola generale è che anche questi crediti prededucibili dovranno essere ammessi come tutti gli altri, (domanda, accertamento del passivo, decreto etc. etc.) salve le eccezioni ex art. 222. Potrebbe capitare che l’attivo è insufficiente a soddisfare tutti i titolari di crediti prededucibili. In questo caso l’ultimo comma dell’art. 222 dispone che la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge. Sempre l’art. 222 al comma 2 dispone che i crediti prededucibili vanno soddisfatti per intero, cioè per il capitale, gli interessi e le spese con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione.
Le ripartizioni parziali e le somme non immediatamente distribuibili
Non bisogna credere che le ripartizioni tra i creditori sono effettuate solo alla fine, e in unica soluzione; la regola, infatti, è quella delle ripartizioni parziali, anche per non far attendere i creditori. Le ripartizioni parziali (art. 227) non possono superare l’80% delle somme da ripartire.
Tuttavia una parte di tali somme non possono essere senz’altro assegnate ai creditori.
Il giudice delegato stabilisce come devono essere trattenute e depositate le quote assegnate:
a) ai creditori ammessi con riserva;
b) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
c) ai creditori opponenti la cui domanda e' stata accolta quando la sentenza non è passata in giudicato;
d) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.
In relazione ai creditori ammessi con riserva, l’art. 228 precisa che quando si verifica l'evento che permette l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.
Pagamento ai creditori, rendiconto e ripartizione finale dell’attivo
Come già detto in precedenza la regola non è quella del pagamento in unica soluzione ai creditori alla fine della procedura, ma il pagamento parziale che segue alle vendite effettuate dal curatore.
Il piano di ripartizione è il riferimento per questi pagamenti e secondo l’art. 230 il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, idonei ad assicurare la prova del pagamento stesso.
Una volta effettuati i pagamenti in esecuzione del piano di riparto, questi non possono essere ripetuti, cioè non possono essere restituiti dai creditori, salvo però che sia stata accolta una domanda di revocazione, e ciò si accorda con la caratteristica di straordinarietà di questo mezzo d’impugnazione previsto dall’art. 206.
Come detto la regola è quella delle ripartizioni parziali, ma queste non possono superare l’ 80% di quella finale.
Quindi avremo le ripartizioni parziali e quella finale, ed è tra queste due ripartizioni che s’inserisce l’obbligo del curatore di rendiconto ex art. 231.
Vediamo tutto nello schema.
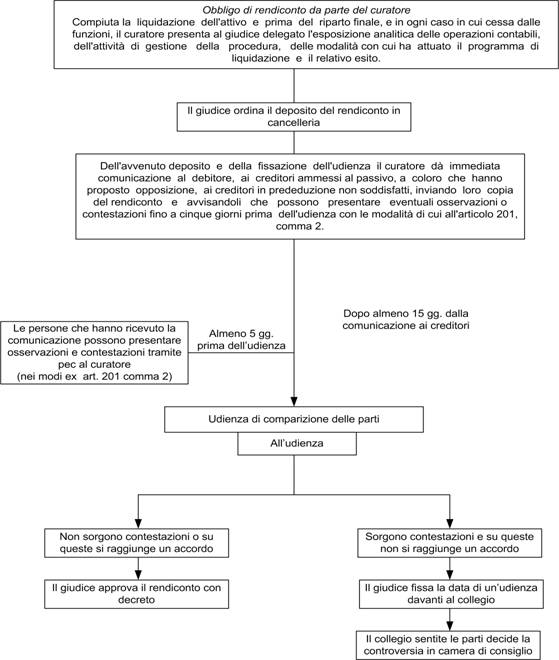
Immaginiamo che il conto sia stato approvato; finalmente si può giungere alla ripartizione finale di cui parla l’art. 232.
Questa ripartizione è disposta dal giudice delegato sentite le proposte dal curatore,e solo dopo che sia stato approvato il rendiconto, e liquidato il compenso al curatore; la ripartizione finale avviene con le regole già viste per le ripartizioni parziali, e cioè tenendo conto della graduazione tra i vari crediti. Con la ripartizione finale sono distribuiti anche gli accantonamenti fatti in precedenza, ma può accadere che nemmeno ora sia possibile distribuire questi accantonamenti.
Può darsi, infatti, che non si sia ancora verificata la condizione, oppure che non sia ancora passata in giudicato il provvedimento per cui era in corso un impugnazione. In questi casi la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato; con questo deposito si attende che si avveri (o che sia certo che non si avveri più) la condizione o passi in giudicato il provvedimento. Avveratisi tali eventi la somma depositata sarà versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.
Una situazione simile riguarda i creditori di cui si accerta il diritto, ma che non si presentano o sono irreperibili. In questi casi le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 131.
Passati cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia.
Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale.
Gli articoli 233 e seguenti si occupano dei casi di chiusura della liquidazione giudiziale.
Le ipotesi sono previste dall’art. 233 e la dichiarazione di chiusura è effettuata dal tribunale con decreto. La procedura di liquidazione giudiziale si chiude:
a) se nel termine stabilito nella sentenza con cui è stata dichiarata aperta la procedura non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
b) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
c) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
d) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di
procedura.
La procedura di liquidazione giudiziale si chiude anche nel caso in cui sia omologato il concordato proposto durante la liquidazione giudiziale; per l’art. 246, infatti, nel caso in cui il decreto di omologazione diviene definitivo, dopo che il curatore avrà reso il conto della gestione, il tribunale dichiara chiusa la liquidazione giudiziale.
Per l’articolo 235 la dichiarazione di chiusura è effettuata dal tribunale con decreto motivato su istanza del curatore o del debitore o anche di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte dall'articolo 45. Insieme all’istanza di chiusura il curatore il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale ex art.130, comma 9.
Il decreto di chiusura può essere impugnato con reclamo alla corte d’appello ex art. 124 e il decreto della corte d’appello che decide il reclamo si può impugnare con ricorso per cassazione.
Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, o quando il reclamo è definitivamente rigettato.
Quando il decreto è divenuto efficace, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. La chiusura della liquidazione giudiziale può portare una serie di conseguenze, vediamole nei paragrafi che seguono.
Chiusura della procedura nei confronti di società
Se la chiusura avviene quando:
1. è compiuta la ripartizione finale dell’attivo oppure…
2. quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura, fatto salvo quanto previsto dall’art. 256 comma 6 relativo ai giudizi pendenti, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.
Chiusura
della procedura nei confronti di società di capitali.
Quando la procedura ha riguardato società di capitali e si è chiusa perché:
a) non state presentate nei termini domande di ammissione al passivo, oppure…
b) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione il curatore convoca l’assemblea ordinaria dei soci. In questa assemblea si deciderà ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione o ancora per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il venti per cento del capitale sociale.
Chiusura
della procedura nei confronti di soci illimitatamente responsabili.
La chiusura della procedura nei confronti della società con soci illimitatamente responsabili avvenuta quando:
a) non state presentate nei termini domande di ammissione al passivo, oppure…
b) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione.
La chiusura della procedura nei confronti della società, come si diceva, comporta anche la chiusura della procedura estesa ai singoli soci, a meno che non sia stata aperta una singola procedura contro un socio, in quanto imprenditore individuale.
Regole particolari sono infine previste ex art. 234 nel caso in cui si chiuda la procedura ma esistono ancora giudizi pendenti.
Effetti della chiusura della liquidazione giudiziale
Sono previsti dall’art. 236, vediamoli:
1. Con la chiusura cessano gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti alla procedura.
2. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo precedente (ex art. 234).
3. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 278 e
seguenti, cioè salvo in caso di esdebitazione.
4. Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile, cioè come prova scritta per ottenere un decreto ingiuntivo non esecutivo.
Casi di riapertura della liquidazione giudiziale
Le ipotesi sono previste dagli articoli 237 e ss.. In primo luogo deve essere accaduto che la procedura si è chiusa con una ripartizione dell’attivo che però non è riuscita a soddisfare tutti i creditori, oppure si è chiusa perché nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura (art. 233 comma 1 lett. c) e d).
Deve poi risultare che nel patrimonio del debitore esistono delle attività che rendono utile il provvedimento di riapertura; questa utilità deve riguardare la soddisfazione anche parziale dei creditori insoddisfatti; sarà il tribunale a valutare se sia utile riaprire la liquidazione.
A queste condizioni si può quindi procedere alla riapertura della liquidazione giudiziale, ma è possibile che anche esistendo dette condizioni non si possa comunque procedere alla riapertura e ciò accade quando il debitore è stato già esdebitato ( artt. 278 e ss.). Con l’esdebitazione, infatti, il debitore è liberato dai crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni. Nemmeno è possibile riaprire la liquidazione quando sono trascorsi cinque anni dal decreto di chiusura della liquidazione giudiziale.
Esistendo le condizioni si può procedere alla riapertura, vediamo la procedura.
1) istanza del debitore o di qualunque creditore, con cui si chiede la riapertura; gli istanti ritengono e documentano che nel patrimonio del debitore esistono attività che rendono utile la riapertura della procedura di liquidazione già chiusa;
2) il tribunale decide in camera di consiglio e se ritiene che esistono nel patrimonio del debitore attività che rendono utile la riapertura della procedura di liquidazione, accoglie l’istanza con sentenza. La sentenza può essere pronunciata entro cinque anni dal decreto che aveva chiuso la liquidazione giudiziale.
La sentenza di riapertura:
a) richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore o li nomina di nuovo;
b) stabilisce i termini previsti dalle lettere d) ed e) dell'articolo 49, comma 3, ( cioè la data dell’udienza per l’esame dello stato passivo e i termini per le presentazione delle domande di ammissione al passivo) eventualmente abbreviandoli non oltre la metà;
i creditori già ammessi al passivo nella procedura chiusa possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.
La sentenza è pubblicata ai sensi dell’art. 45 ed è impugnabile a norma dell’art. 51, cioè nei modi in cui s’impugna la sentenza sulla liquidazione giudiziale.
Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori mentre per le altre operazioni si seguono le norme stabilite per la liquidazione giudiziale.
La particolarità della riapertura sta nel fatto che possono partecipare i vecchi creditori ma anche i nuovi creditori del debitore che subisce la riapertura. I vecchi creditori, come visto, potranno semplicemente chiedere la conferma del vecchio provvedimento di ammissione al passivo, salvo che vogliano insinuare al passivo ulteriori interessi. I nuovi creditori dovranno invece trasmettere al curatore la domanda di ammissione al passivo. Si procede quindi come già visto per la liquidazione giudiziale, fino alla liquidazione del nuovo attivo ricavato dalla vendita dei beni del debitore. Concorreranno su questo attivo i vecchi creditori e i nuovi creditori.
I vecchi creditori concorreranno alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione secondo quanto già accertato nella precedente procedura di liquidazione giudiziale. I nuovi creditori concorreranno per la prima volta alla ripartizione secondo le regole già viste per la liquidazione giudiziale. Nel caso in cui vi siano stati atti pregiudizievoli ai creditori ex artt. 164 (pagamenti di crediti non scaduti e postergati), 166 (atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie) e 167 (atti su patrimoni destinati ad uno specifico affare) i termini saranno computati dalla data della sentenza di riapertura e non della prima sentenza che ha dichiarato la liquidazione giudiziale. Sono poi privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e gli atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto ( cioè gli atti ex 169), successivi alla chiusura e anteriori alla riapertura della procedura.